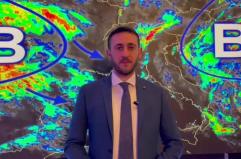di Pietro Sisto
Il Seicento, a detta di numerosi studiosi, è stato un secolo di grandi, insanabili contraddizioni: della scienza nuova e della caccia alle streghe, dello splendore barocco e della censura religiosa, di ricchezza e miseria, di feste spettacolari e di eventi luttuosi. E di questo panorama di luci e ombre, di vita e di morte fecero parte a pieno titolo Napoli, la Puglia e soprattutto Bari messa in ginocchio da una ripetuta serie di carestie e dalla pestilenza del 1656 che, tra l’altro, devastò gran parte del regno, compresa la capitale.
In realtà, non si erano ancora dimenticati i dolori e i lutti del contagio che fu necessario salutare la nascita del reale infante Filippo Prospero, avvenuta il 27 novembre del 1657, con festeggiamenti straordinari soprattutto nella corte partenopea perché con la scomparsa del fratellastro, il principe Baltasar Carlos, avvenuta nel 1646 a soli 16 anni, la casa reale era rimasta senza eredi maschi.
E come a Napoli i festeggiamenti si tennero nel Carnevale del 1658 con cavalcate, cacce di tori, luminarie e rappresentazioni teatrali, così a Bari per tre giorni e tre notti si organizzarono riti e spettacoli di ogni genere: Te Deum ed «eloquentissimi panegirici» nella cattedrale e nella basilica di S. Nicola, lumi e fiaccole sugli edifici principali, squilli di trombe e rintocchi di campane, rulli di tamburi e spari di cannone dal castello, mortaretti, balli e canti nelle strade: «Per tre sere di continuo – scrisse F. Veniero in Bari festante (Zannetti 1658) - dal tocco dell’Ave Maria sino la mezza notte scorsa, con arredi di non brevi faci e grosse ai balconi del governatore, prelato commune, monsig. priore, sindici, nobili e patritii, coll’avanzo de regii officiali, vagamente vagheggiavansi, numerosi lumi indifferentemente abbellivano d’ogni casa i balconi, tra quali sembravano tante lune splendoreggianti sembianti di dame che spettatrici, non men che osservanti delle communi allegrezze, i lumi altrui invaghiti ad invaghirsene invogliavano». E proprio perché anche da queste parti era Carnevale, il governatore ordinò che «tutti si mascherassero, ogni giorno quindi giocondamente hora un’arte, hor l’altra a vicenda, con divisati ma ridicoli ammanti sotto finti personaggi, feasi festante per la città vedere».
Ma lo spettacolo più sfarzoso ed elegante fu offerto da una «nobilissima cavalcata in maschera» preceduta da un «trombettiere di vermiglio ammanto strisciato d’argento». Composta da sei quadriglie, era aperta dal governatore, dal sindaco della città e dai patrizi più in vista, che indossavano abiti di colore «leonato» con gemme artificiali e ornamenti di argento per sottolineare la lealtà e la purezza del loro sentimento nei confronti della Corona. E poi al seguito nobili e cavalieri, con abiti di diversi colori, tra i quali spiccavano soprattutto il rosso, simbolo del sangue che erano disposti a versare per il principe, e il verde per la speranza che riponevano in lui, con spade luccicanti e cimieri piumati che al vento sembravano quasi formare un grande arcobaleno della pace. Alcuni di loro accompagnati da «numerosi servi» con cesti pieni di «variate confetture» lanciavano dolci e confetti alle nobildonne affacciate ai balconi, mentre bambini e pitocchi cercavano di raccogliere quelli caduti tra gli zoccoli dei cavalli. E la festa, aggiunse Veniero servendosi appieno delle colorite, immancabili metafore della prosa secentesca, sembrò quasi coinvolgere persino il mare dove «guizzanti balli trahendo brillavano nell’onde i muti e squamosi notatori, rendendo gioiosi tributi al lor nato Nettuno».
Insomma, un vero e proprio trionfo per la casa regnante e per re Carnevale, che però non fu sufficiente ad assicurare al giovanissimo principe una vita lunga e felice: dopo appena quattro anni, narrano malinconicamente le cronache del tempo, «il bambino se ne volò al cielo» non curandosi affatto di due città e di un intero regno che erano stati così a lungo e così sinceramente in festa per la sua venuta sulla terra. E insieme a quei festeggiamenti nulla potettero fare sul suo corpo, piccolo e malaticcio, amuleti e portafortuna di ogni genere che a corte gli fecero indossare nel corso della sua brevissima, sfortunata infanzia e che Diego Velazquez non mancò di dipingere nel famoso ritratto dell’Infante Felipe Prospero destinato a rivelarsi ugualmente, inutilmente beneaugurante.
Così, sulla festa più fastosa e allegra, che aveva fatto salire contemporaneamente sul «trono» re carnevale e un bambino/sovrano, si allungò l’ombra «barocca» e sinistra della morte. Del resto lo stesso Veniero aveva concluso quel racconto luccicante e carnevalesco con il mesto ricordo delle numerose vittime della pestilenza del 1656, servendosi di parole e immagini così forti e inquietanti da apparire già dopo pochi anni quasi come un triste presagio per il «principe delle Spagne»: «strano non sembri poi che tall’ora tra i serenissimi campi dell’Etra ai ridenti e giocondi rai solari frappongonsi nubi importune».