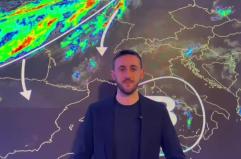di ALBERTO SELVAGGI
Scusa, chi sei tu, Nichi Vendola, presidente della Regione, governatore, roba del genere? Vieni qui, bello allo zio. E tu, Paola Concia, i pax, le cose, l’omo e la trans-fobia. E tu, Franco Grillini, Arci-inverter, tenzoni dialettiche vaticanesi. E voi, altri fighetti dei negozi baresi che ve la tirate manco Valentino (un genio) o Dolce & Gabbana (Artisti magnifici), tesserati alle saune, ai locali «in» transgender, ai resort convenzionati gay-friendly, immunoprotetti intellettualesi Lgbt/ci, e quanti ne siete: in ginocchio, e muti davanti all’aura di chi ha combattuto per i diritti al modo più chiassoso, scriteriato, stradaiolo, sub-proletario, teatrale e volgare osceno nei tempi dei pionieri. Sguardo a terra, per la miseria, davanti a chi ha fatto di un’intera vita un gay-pride in solitaria perenne: Lorenzo De Santis, detto «Varichina», primo, anzi unico omosex oltranzista, urlante, pressoché animalesco della storia incolore di Bari.
Io canto il mito di Varichina, da pronunciarsi con l’erronea «i» e giammai con la «e». Il personaggio, con Piripicchio, più famoso di sempre. E che i tombini, più che la musa, mi assistano.
Amato, citato dagli accattoni come dai notabili celebri, con la sua zazzerona sconnessa e riccia color acqua marcita, schiumata di rame biondastro alterno, coi suoi pantaloni a zampa strizzati su chiappe e pudenda, con le sue camicie ad alettoni marron-blu tenebra col nodo sul ventre, inimitabili nella sublimazione dell’abominevole, coi suoi «l’ femmn hann’ a murì e tutt’ ddò avìt’ a frnèsc», «rdìt, rdìt’, ke tutt ddò dret’ avìt a vnì» gridati da decine di metri battendosi col palmo il gluteo in sculettio virulento, con i «cciè vol’ da me kessa zògn» (uomo), «ciao bello!» rivolti alla cieca data la grave miopia, con il cabaret a bordo del bus n. 12, i motteggi alle lucciole da porno cinema, «send’ nu fiiìzz d’ picc…», ricchionerie da D-movie, non B, irresistibili, con i botta e risposta coi ragazzi molesti, Lorenzo si impossessò dell’immaginario fin dai primi Settanta donando a ogni cittadino una gag da riferire, donne comprese.
Da oltre un ventennio era svanito nell’ombra del mito: alcuni lo davano morto in terra straniera, per setticemia, overdose di ero, altri collassato in una casa di cura in provincia, altri ancora – leggenda nata da alcuni infermieri –, come Jim Morrison o Moana Pozzi ancora vivo pur se ai minimi termini. In questi giorni i fan cercavano per l’ennesima volta nostalgicamente lumi sui forum inneggiando all’avanguardista della diversità trash. E quindi è giusto far sapere che Varichina è ancora nella città natia; che il 26 aprile 2003 si è trasferito nel seminterrato della chiesa di San Francesco, campo 20, lotto 322, in via Crispi, con un mazzo di gigli finti e una fiamma perpetua sul marmo di neve; e che sua sorella Rosa, classe ’23, primogenita che gli somiglia parecchio, unica superstite della famiglia, sul balcone al secondo piano di via Dante, con la solita bandana gialla marrone sulle tempie guarda il cimitero vicino e pensa: «Lore’».
Varichina nacque da Biagio De Santis e Vittoria Aprile sotto la stella bizzarra dell’avvenire il 27 settembre 1938. Si impossessò presto di una inflessione «filo-barivecchiana» gutturale stretta che rese le sue stravaganze ancora più pregne. Ultimogenito dopo Rosa, Antonia, del ’25, e i gemelli Gaetano e Giuseppe, ’34, «venne sconosciuto» (ripudiato) dalla famiglia, come ricordano gli amici gay dell’epoca, fin dai primi vagiti «di malattia» (omosessualità). Ne soffriva ancora, a fine anni Ottanta lo ripeteva, consolato dagli amanti «che lo sfruttavano spesso», che «facevano i fatti loro e poi lo buttavano a mare», o da una vicina al pianterreno di via Garruba 110, la stamberga volante del suo epos, e «certe volte piangeva».
Lo soprannominarono Varichina perché da ragazzo, dopo essere stato garzone di latteria per le periferie, vendeva candeggina in bici e la utilizzava a tempo perso come sguattero a nero nel Policlinico e nei pubblici cessi. Ma la verve, l’invenzione, l’effervescenza talvolta violenta, e quella deformante inclinazione caricaturale sopra le righe, al Libertà lo resero inconsapevole emblema del riscatto dei gay.
Che vita la vita da Varichina. Campava tra la ex Posta centrale e i giardini davanti a Giurisprudenza, «piazza Umberto», come ancora oggi alcuni gay settantenni e ottantenni chiamano piazza Cesare Battisti. «Era il nostro regno», racconta Francesco, 80 anni, «le puttane stavano dall’altra parte dell’Ateneo». C’era un pisciatoio in ferro a due posti, sede per pattuire, talvolta consumare incontri di sesso. «D’estate andavamo sugli scogli del molo Sant’Antonio, in pineta, ad abbordare nei cinema», racconta Vincenzo, 76 anni, amico e quasi coevo di Lorenzo, luccicante e lustro ancora come un gioiello. E «il molo col faro» era citato anche nella Guida Omosex semiclandestina dell’epoca. Oppure «cercavamo alla stazione centrale i soldatini» per consumare negli alberghi a ore vicini, nel monovano di un marchettaro che menava lì squallida vita. «O nei wc finché erano gratuiti e sistemati all’esterno della ferrovia. Oppure andavamo alla Moscia», vicino alla Fiera, allo Stadio vecchio, nei piazzali alle spalle dell’ei fu macello, «in macchina o in piedi». Poveri, benestanti, «velati» (sposati), ricchi come un noto industriale e un famoso medico che ha deposto i ferri. Come alcuni politici di scuola fine.
Una volta Varichina in piazza Battisti, che fu un rigoglioso giardino oggi degradato in schifezza, cantava Stasera mi butto (Rocky Roberts) alla sua maniera, facendo allontanare per l’imbarazzo gli uomini che pure condividevano i suoi desideri. «Gli piombò alle spalle un fratello cuoco del Policlinico e lo crepò di mazzate», ricorda Giovanni, quattro nipoti e due figlie. Un’altra volta salutò un magnaccia: «Amore, ti voglio bene!». La puttana si insospettì: «Come, sei stato con un ricchionazzo?». L’uomo riaccompagnò a casa la peripatetica, tornò verso la Posta e lo fece nero.
Tutti però ricordano i decenni precedenti ai movimenti per l’integrazione come felici, sereni sul fronte del sesso: «Ci conoscevamo tutti, al peggio c’erano i ragazzini che ti sfottevano, nessun pericolo. La paura, i pestaggi, gli omicidi, le rapine sono arrivati con gli immigrati, che vogliono solo moneta: georgiani, marocchini, rumeni, tunisini…».
Che impresa essere Varichina. Rientrava dalle sue scorrerie nella «mansardina» di via Garruba, lassù nel nido sospeso in cui campava come un uccellaccio tremendo. Cinque o sei metri quadrati, volta a botte ristretta, una finestra di un metro e mezzo, nemmeno, che affaccia sul giardinetto interno e che fungeva anche da ingresso attraverso una scala fetente di legno. È ancora lì, convertita in deposito-archivio. Che emozione metterci i piedi, guardare giù attraverso le lenti di Lorenzino. Una sistemazione pazzesca con accesso dal portone attraverso una porticina. Ci stava un letto a stento, per bagno «’nu prìs’», un pitale che lui vuotava «nel gettatoio» accanto al lavandino al pianoterra tra l’erba. Per riscaldamento l’ardore di amanti che fuggivano presto: «Lo cacavano sempre», racconta un’amica. Certe volte giovani ubriachi lo prendevano a bersaglio con sacchetti dell’immondizia e Peroncini, e lui, dopo aver menato allucinatorie bestemmie, quando non calci e sberle, riparava dalla vicina che abitava nell’atrio, se stretto d’assedio: «C’era chi gli riempiva di gamberetti il letto per scherzo».
L’età d’oro dei cinema a luci rosse diede nuova spinta alla clandestinità gay. Al Marilon soprattutto, e poi nel Salottino, alcuni si offrivano di placare l’eccitazione dei giovani sulle poltroncine infette «o nei bagni o nelle auto, se arrivavano signori muniti», ricordano i leoni incanutiti.
E anche per il nostro eroe cambiò la vita: ogni tanto vendeva biglietti, allo stadio e della Lotteria. Si inventò parcheggiatore abusivo davanti a Giurisprudenza, docenti, avvocati, studenti, «uè, Uarìnz’!». «Al mattino faceva da guardiano assistente alle prostitute» dei cubicoli sul Lungomare verso San Giorgio, ricorda un frequentatore di quella miseria: e d’estate lo sfottò volante, il gavettone sulle sue spalle massicce per i giovani in scooter erano regola.
Nel settembre ’90 l’appartamento che includeva il contiguo nido-tugurio venne venduto «con Varichina dentro, e noi, che non sapevamo niente della sua presenza, lo trovammo lì come una bella sorpresa», ricordano gli acquirenti. Ma il nuovo proprietario, munifico, e che ovviamente non era barese, avviando la ristrutturazione gli offrì, con contratto di comodato d’uso, «aggratìs», un suo sottano bivani di via Ettore Fieramosca 202, due passi dal Mercato: «Quando sei nato?» gli chiese per la stipula. «Ci iè?!». «Di che anno sei?».
Soltanto chi è cresciuto al Libertà può dirsi figlio del popolo sul serio. Ma in quella via del quartiere Lorenzo si vide con minore frequenza. Dopo qualche anno, mentre usciva dalle stamberghe delle prostitute orrende stringendo un secchio, venne investito. Una grave ferita a una gamba che le sue cellule non riuscivano a sanare anche causa diabete. Dio gli mandò la dea Malattia come messaggera a dirgli che voleva vederlo presto. Glucosio a palla, insulina sfinita, complicazioni connesse, trattamenti, siringhe, pensione di invalidità, scompensi cardiaci. Lo portarono alla Sanatrix (oggi un complesso residenziale), in un’ansa di viale Salandra, proprietà di Francesco Cavallari detto «Cicci». Aggravamento ulteriore e una gamba in cancrena, zac, andò via. Un ex amante lo incontrò lì all’ingresso, sceso dall’ambulanza in carrozzella: «Be’, che è successo?». Risposta: amare gasteme.
Finì a Triggiano, in casa di cura, e la seconda gamba venne amputata di netto. Barca senza remi e senza documenti, l’ultima carta di identità risale al ‘91: «Celibe». La capigliatura fluente, torrenziale, imbizzita, così naturalmente ribelle, nel calvario delle stazioni ospedaliere si mitigò in un taglio rarefatto e modesto. Le sue guance si incavarono come quelle dei teschi, finché le orbite in un ricovero d’urgenza salutarono i soffitti del Di Venere per sempre.
E adesso che siamo entrati nel decennale della morte di Varichina. Adesso che abbiamo, pur nella pochezza di una pagina inchiostrata per breve vita, riconsegnato il mito al mito: erigiamo un busto bronzeo al capostipite, all’eroe gay di tutte le guerre, visto che ne abbiamo dedicato uno financo all’assai noto, e tanto amato a Bari, «Nicola I Petrovic Re del Montenegro 1841-1921», in corso Vittorio Emanuele. E voi, se siete davvero compagni, se siete davvero fratelli, inchinatevi, per la miseria, davanti a quest’uomo che tutti abbiamo chiamato Lorenzo.