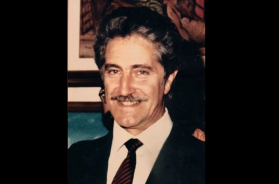È diventata una saga dai tratti noir la vicenda dell’ex Ilva, oggi Acciaierie d’Italia. Una storia dove il confine tra attori e comparse si dissolve in una confusione sistemica, mentre il protagonista - lo Stato - appare indeciso sul ruolo da recitare: arbitro, regista o semplice comparsa?
Al centro della scena, due strumenti decisivi che procedono ora affiancati, ora intrecciati: l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e l’Accordo di programma. Il primo è un atto tecnico-ambientale finalizzato a regolare l’impatto industriale sugli ecosistemi. Il secondo è un dispositivo politico-industriale per ridisegnare il futuro della siderurgia pubblica italiana. Eppure, quella che doveva essere una distinzione netta tra livelli amministrativi e strategie industriali si è trasformata in una convergenza forzata. Volontaria? Forse no. Ma funzionale a chi vuole vestire i panni di primo attore e di chi ha fretta. Il ministro Adolfo Urso, in particolare, vuole chiudere tutto entro luglio. L’8 ha convocato, insieme al ministro dell’Ambiente, un vertice con gli enti coinvolti. Due giorni dopo, il 10 luglio, scadrà il mandato dell’organo ambientale. La pressione è massima. Anche perché incombe l’ukase in stile zarista del Tribunale di Milano, pronto a decretare la chiusura degli impianti in caso di mancato adeguamento. Il presidente Emiliano, da parte sua, minimizza: «La sentenza non sarebbe né definitiva né esecutiva». Alle brutte, c’è sempre l’Appello. Ma intanto il tempo corre.
I lavoratori? Diecimila «sardine» - contando i cassintegrati e senza gli indiretti dell’indotto - in mezzo: sotto, divorate dai tonni; sopra, aggredite in picchiata dai gabbiani. Fuor di metafora: tra crisi industriale a spese dei lavoratori e governo, una impasse sempre più preoccupante. Sul fronte sindacale, il clima è tutt’altro che collaborativo. Le sigle non vogliono delegare né mediare. La corda sta per spezzarsi. Sicché, pretendono un confronto diretto con il governo e non vogliono invasioni di campo come sta succedendo. Ognuno deve fare il proprio mestiere: a ciascuno il suo. E non è solo questione di forma. Perché i commissari straordinari, tra questi , in particolare l’ingegnere Gianfranco Quaranta, - conoscitore esperto dello stabilimento, con un know how di prim’ordine - possono fornire relazioni dettagliate, ma non esauriscono il quadro politico, occupazionale e sociale della crisi.
La questione industriale è infatti complessa. Al momento, lo stabilimento produce a malapena 2 milioni di tonnellate annue, grazie al solo Altoforno 4. L’Altoforno 1, ripartito con grande enfasi mediatica, è stato sequestrato dalla magistratura dopo la rottura di una tuberia e il conseguente incendio. Le acciaierie producono poco perché c’è poca ghisa: acciaieria 2 si è fermata - dopo la riattivazione della 1 - per consentire la manutenzione del gasometro a essa collegato. Manutenzione effettuata. Gli altri impianti versano in condizioni ignote. La verità è che Acciaierie d’Italia brucia cassa. E senza investimenti, manutenzione e una governance stabile, non c’è piano industriale che tenga.
Nel frattempo, i nomi dei potenziali acquirenti - Baku Steel, Jindal, Bedrock Industries - rimbalzano nei dossier ministeriali. Ma l’operazione di cessione è tutt’altro che chiusa. In mancanza di un compratore unico, si riaffaccia l’ipotesi dello «spezzatino»: vendita separata di impianti, opzione invisa ai sindacati. Rocco Palombella (UILM) ha già denunciato l’interesse di gruppi italiani pronti ad acquisire asset dello stabilimento, con il corollario di tagli occupazionali e chiusure. In contrapposizione, si rilancia la statalizzazione: opzione estrema, ma sostenuta da molte sigle metalmeccaniche. Una proposta che trova però un muro nel ministro Giorgetti, più attento a conti pubblici, dazi e spese militari che alla tenuta dell’industria pesante. Il rilancio del Mezzogiorno non passa dalle acciaierie, nei suoi radar.
Ma i nodi industriali non si fermano qui. Due sono i temi tecnici più caldi nell’Accordo di programma: la localizzazione della nave rigassificatrice e la costruzione del dissalatore. Per la prima, si valuta un attracco fisso nel porto, come a Piombino, o offshore, a 8 km dalla costa, modello Ravenna. Per il secondo, si ipotizza una piattaforma in mare, da cui ricavare acqua industriale. Emiliano prova a rilanciare: la salamoia prodotta non verrebbe rigettata in mare, ma trattata e trasformata in business circolare. Da non confondere con il dissalatore dell’Acquedotto Pugliese, progettato sul fiume Tara per usi civili, ma oggi sotto esame per il possibile impatto sull’ecosistema. Sul rigassificatore e sul dissalatore pesano i malumori delle frange ambientaliste che sostennero, in campagna elettorale, l’attuale sindaco. Che però - per forza di cose - ha cambiato idea. Non solo lui, in verità. Come le nespole: col tempo e la paglia maturano. In bene come in male. Secondo la recente vulgata, i «bitettiani alias melucciani» sono costretti a subire decisioni calate «insù e ingiù» da soggetti esterni.
C’è poi l’aspetto sanitario. Il presidente della Regione Puglia segnala criticità ospedaliere croniche. Il nuovo mega ospedale San Cataldo, completato da mesi, non è ancora operativo. L’idea - al momento poco più che un’ipotesi - è rifunzionalizzare il Santissima Annunziata in IRCCS, anche per le patologie industriali connesse all’esposizione ambientale. Sicché si ritorna sul luogo del delitto. Ma servono risorse, personale e, soprattutto, volontà politica. Infine, la richiesta chiave dei commissari: l’AIA deve autorizzare una produzione di 6 milioni di tonnellate annue, con tre altiforni in esercizio fino al 2039. Perché? Perché a quella soglia scatta l’economia di scala. L’industria torna redditizia. Ma per raggiungere davvero la decarbonizzazione, non non basta l’autorizzazione ambientale. Servono gli impianti DRI (Direct Reduced Iron). E quelli non si costruiscono in poche stagioni. L’ambientalizzazione - cioè la riduzione degli inquinanti - è in corso, e già colloca Taranto tra i poli più monitorati al mondo. Ma il salto alla siderurgia verde - non illudiamoci - è ancora un orizzonte lontano. Non è divertente prendere in giro i tarantini quando si gioca sulla loro pelle.
E allora, mentre la politica annaspa, la fabbrica va in declino e in degrado. Gli operai attendono. I cittadini diffidano. I tempi si accorciano. E questa vicenda, se non si scioglie in una direzione netta, rischia di passare dalla farsa istituzionale alla tragedia industriale.