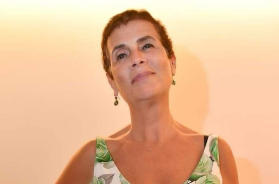«Parthenope» è la naturale continuazione de La mano di Dio. Lo dico da spettatore, lettore. Si ritiene che ogni libro sia autobiografico, di qualsiasi cosa parli. E figuriamoci un film che aggiunge l'immagine non statica alla parola sonora, carica di espressione e non mummificata su carta.
Quindi, Paolo Sorrentino ci parla della sua città in sé. Riuscendo, al tempo stesso, a guardarsi da fuori. Ed è così vero (l'artista mira a trasfigurare quanto è personale, per renderlo universale), che sembra temere sia troppo palese e cerchi di portare lo spettatore fuori strada, facendo dire al professore: «Alla fine della vita resterà solo l'ironia». Non è vero: l'ironia è «il dolore che scorre con il tempo», il cadavere di un ideale, un sogno irrimediabilmente perso. Non compare alla fine, ma subito e, come la diminutio ostentata (understatement alla Sorrentino), è un nascondiglio del male di vivere. Il professore avverte che Parthenope cela come lui una frattura irrisolvibile e quasi tenta di dissuaderla dal seguire le sue orme, perché «poi si diventa come me».
Non sono un critico cinematografico, ma ho, come tutti, il diritto di farmi incantare, sorprendere, interrogare, disorientare, riempire, commuovere.
Ci sono tanti film in Parthenope (citazioni a parte), ma di ognuno, Sorrentino ha preso la scena più alta e buttato il resto. Per questo, penso sia sbagliato vederlo dall'inizio alla fine, tutta una tirata: ci sono cose che hanno bisogno del loro tempo per srotolarsi, essere ascoltate. Sarebbe come dire a un poeta, dopo il primo verso: «Sì, ma come finisce?». Il finale di un'opera è un vezzo dell'artista, 'a cerasa 'ngopp'a zeppol'e san Giuseppe; tant'è che lo si può cambiare, perché non è una conseguenza, ma una chiusura (a coda di topo, a effetto, col botto, con il sorriso o la lacrima, con una piega amara o un raggio di speranza...). L'opera è il percorso, ce l'ha detto Kavafis: Itaca potrebbe non esistere.
E per i pezzi di troppi film uno dopo l'altro, alcuni spettatori, nella prima parte di Parthenope, non riescono a scorgere il filo che li unisce. C'è chi, infastidito, borbotta: «Vabbuo', ma la trama?». Per ascoltare davvero, bisogna lasciarsi andare. In ogni racconto, l’attesa della rivelazione misura l'entità della rivelazione: la creatura di acqua e sale («come il mare»), la vedi alla fine perché, dopo averti costretto all'immaginazione, la supera e ti sorprende.
La trama di Parthenope è la somma di quelle dei pezzetti di film ridotti a una scena o poco più. Per questo (colpa mia e della lentezza di riflessione), ci ho messo giorni a vedere Parthenope.
Credo che solo un napoletano possa dire che «L'antropologia è vedere». Se tale disciplina studia i comportamenti umani, perché applicarla a una città, che andrebbe invece indagata dalla sociologia o riscoperta dall'archeologia? A Napoli, l'antropologia diventa archeologia, perché questa, lì, non è «i resti della storia di ieri», come a Roma, dove il passato è nelle rovine (il Colosseo, la via Appia o altro di pietra); o a Milano dove, paradossalmente, l'archeologia è nel futuro, in quello che vuole diventare: non una città, ma un'idea di civiltà, quindi eterna, come Napoli, Roma o altre che restano nella storia, pur non esistendo più nella geografia.
Roma fu, Milano vuol essere, ma Napoli è. John Turturro, a commento del suo film sulla musica napoletana, Passione, lo ha detto bene: «Ci sono tante città. E poi c'è Napoli». E persino meglio Jean Noel Schifano: «Sparisse tutto il mondo e restasse solo Napoli, non avremmo ancora perso niente».
A Napoli, l'archeologia è il presente, perché «i resti del tempo» non sono nei sassi residui o nelle ambizioni, ma nel vivere quotidiano, nei comportamenti, appunto. Napoli è una farfalla che dura un giorno, ma nasce ogni giorno. I bassi hanno il letto, non la cucina: si crea vita, non la si coltiva: io ti faccio, la città ti campi. Senza la necessità di far rima, ci sarebbe stato turnarraggio, uno dei rari futuri del napoletano, in Era de maggio?
L'antropologia di vedere, nel film di Sorrentino, va dal sublime al banale dichiaratamente tale, vedi i fotogrammi (pochi, ma ci stanno) dell'uomo attaccato al camion d'a munezz, che mangia il panino in attesa del prossimo bidone da svuotare.
Parthenope è bella, colta, benestante, della città «alta» (la Napoli della cultura e dei soldi, pur beceri ma veri e tanti di Lauro), di solito insofferente di quella bassa dei quartieri, dei vicoli. In cui la protagonista si immerge, da antropologa (alla Malaparte, altra citazione?), guidata da uno che da lì proviene, ma accetto dai «signori», perché ricco. Anche se i suoi sono i soldi del marciapiede, del vizio: in fondo, è un fornitore. E si compie «la grande fusione»: nella carne, ovvero nell'essenziale, il cibo, il sesso (la mano della «direttrice» che sulla natica del ragazzo imprime il ritmo all'amplesso è un colpo di genio). E la grande fusione la fa anche Parthenope: dalle sentine all'altare (mentre il sangue di san Gennaro si scioglie: quindi consente), a gambe aperte, perché da lì scorre la vita. La fusione potrebbe riuscire, Parthenope rimane incinta, ma abortisce. Come Parsifal, manca la prova decisiva che avrebbe fatto rifiorire la Terra Desolata, non facendo la domanda al Re Pescatore: «Per chi è il Graal?».
Napoli, nata plurale (sannita e greca ma di più apporti greci e altre genti mediterranee), plurale resta, non diventerà una. E l'essere irrisolti rende creativi, perché obbligati da una differenza, un difetto di fondazione, meglio se irrecuperabile (vale pure per Sorrentino. E qui mi fermo). Solo i vinti costruiscono visioni di nuovi mondi, per sottrarsi alla propria condizione (i più la accettano, perché stanchi pure di sperare, e si prendono gli insulti dell'attrice: sono colpevoli. Di aver perso). I vincitori hanno interesse a conservare la condizione che li vede al vertice. Persino chi è al vertice della gerarchia dei vinti è conservatore. E complice. La rivolta giovanile («Uniti si vince») suggerita da Sorrentino potrebbe venire solo dal basso, dagli ultimi.
Paradossalmente, una identità forte come quella napoletana, tanto da rappresentare un mondo, se non il mondo, è possibile solo se aperta a tutto. È vero, «i mondi si stancano», ci si dice nel film, ma Napoli-Parthenope è femmina, quindi la sua funzione biologica è l'accoglienza (dell'inseminatore, della vita), pronta a ogni intrusione, dominio e servizio. È la città «dove c'è posto per tutto». E il napoletano è di fatto apolide, perché identità non è essere qualcosa, ma fare le cose di tutti in un modo che rende inconfondibili: Napoli è ultima fra le grandi città a ricevere il caffé «ma sul' a Napule 'o sann fa'», il babà è polacco, 'o raù francese, il pomodoro americano, la mozzarella di bufala saraceno-longobardo-normanna.
L'estraneo insopportabile, il nemico, di un napoletano è un altro napoletano (giacubbine/lazzari).
Parthenope è zoccola, condannata a esserlo dalla necessità dell'inarrivabile fusione, dalla storia e dal mito. Religiosamente zoccola, come le prostitute sacre dei templi costieri del Mediterraneo che, quale preghiera, si davano per devozione, ornate di campanellini, per informare dell'esercizio in corso, poi girando il corrispettivo al tempio. Proprio a Napoli, una quarantina di anni fa, Rafael Alberti mi raccontava che, da ragazzini, le puttane di Cadice davano loro... una mano, avendo al polso braccialetti di campanellini, i cascavel (per dire che non sempre l'archeologia è noiosa).
Parthenope è la sirena da cui nasce Napoli, ma muore vergine, perché ha fallito il suo compito: sedurre Odisseo. Per quanti letti possa poi passare, non si può «rimediare alla vita». Ma «era già tutto previsto», ricorda la canzone di Cocciante che viene ripetuta nel film: quando Odisseo passa dalle Sirene, è già stato da Circe e il destino compiuto. Lo dice l'indovino Tiresia che l'eroe raggiunge nell'oltretomba: ti ucciderà tuo figlio «e la morte verrà a te dolce dal mare/ ti coglierà indebolito da serena vecchiezza». Non servirà allontanare Telemaco da Itaca. Odisseo non sa che Circe ha partorito un figlio suo, Telegono, che divenuto uomo va in cerca del padre. Il quale lo affronta dalla riva dell'isola, credendolo un aggressore e ne viene ucciso.
Parthenope non potrà cambiare una storia scritta dal Fato. Era già tutto previsto.
A dissentire da Sorrentino e il suo film sono più spesso dei napoletani. Perché ognuno di loro crede di sapere cos'è la propria città, ma conosce solo «la propria». E Napoli non è una, ma plurale. I napoletani, in questo caso, sono nella fisica dell'immensamente piccolo: la vedono al microscopio; mentre per capirla meglio, bisogna allontanarsi, guardarla da lontano: Pino Daniele «era Napoli», e andò a vivere altrove; l'attrice-Loren, del film di Sorrentino, crede di essersi «salvata» da Napoli, andando su, al Nord, ma nella banalità delle feroci parole che pronuncia, nell'odio, nel disprezzo, si misura il peso della rinuncia (devi denigrare quello che ti costringi a perdere, per diminuire il dolore della perdita). E in questo non potrebbe essere più napoletana.
Il fratello di Parthenope si uccide perché confonde «l'irrilevante con il decisivo». Ma temo che a Napoli accada più spesso il contrario.
Da questo film si esce con tante domande che possono durare una vita. E forse non è davvero importante giungere alle risposte. Il vero capolavoro di Sorrentino (parzialmente disvelato) è questo.