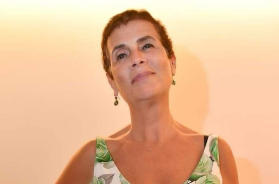Talos, il gigante-robot del mito greco, dallo scorso 19 ottobre accoglie di nuovo i visitatori nel Museo Jatta di Ruvo. Il leggendario colosso - che aveva il compito di impedire ai forestieri di approdare illegalmente sull’isola di Creta, e perciò ne ripercorreva scrupolosamente e continuamente il perimetro - è raffigurato, languidamente morente e sostenuto dai due Dioscuri, sul cratere più significativo della collezione Jatta. Collezione che testimonia quel furore di scavi, leciti e illeciti, che nella prima metà dell’800 portarono a Ruvo compagnie pubbliche e private, tutti alla ricerca dei tesori archeologici (quelli che ora abbelliscono molti grandi musei europei, e non...).
In un certo senso, a Ruvo il mitico Talos ha operato una discreta guardia, affinché non tutto il patrimonio archeologico della città si disperdesse. Grazie comunque ad appassionati collezionisti, come lo furono Giovanni e Giulio Jatta, che accumularono migliaia di reperti di valore, ma soprattutto grazie a Giulia Viesti, la vedova Jatta che non finì per cedere la prestigiosa collezione al Real Museo Borbonico di Napoli, ma volle affidare questo tesoro di bellezza alla Puglia (la collezione si formò soprattutto tra il 1820 e il 1835; nel 1993 è stata finalmente acquistata dallo Stato italiano).
Di quel furore e fervore di scavi e di acquisti archeologici si parlerà in questi giorni a Bari, nel convegno internazionale «Archeologia in Puglia in età borbonica», a cura di Luca di Franco, Gianluca Mastrocinque e Francesca Mermati. Proficuamente.
Nella prima metà del XIX secolo, infatti, si assisté in Puglia a una ricerca spasmodica nel sottosuolo: da Egnazia a Ceglie del Campo, da Canosa a Ruvo..., «la speculazione de’ scavamenti giunse al furore», scriveva nel 1844 Giovanni Jatta.
Per rimanere a Ruvo, nel 1810 era stata scoperta una tomba il cui corredo vascolare, ritenuto straordinario, prese subito la via per Monaco di Baviera. Jatta si riferiva soprattutto a ciò che era avvenuto nel 1822 nella cittadina pugliese. E difatti, proprio in quello stesso anno, viene emanata dal re Borbone - considerata la immensa dispersione di un tale patrimonio storico e archeologico, soprattutto di vasi figurati - una normativa per vietare «di asportare fuori dai nostri Reali Domini ogni oggetto di antichità, o di arte, ancorché di proprietà privata».
Naturalmente la proibizione tendeva a impedire che i reperti varcassero la frontiera del Regno di Napoli. Ma nulla si fece affinché essi fossero ammirati e conservati nei luoghi dove emergevano, magari istituendo appositi musei o collezioni pubbliche: difatti, gli scavi promossi a Ruvo dallo stesso governo borbonico, o gli acquisti dai privati scopritori, erano funzionali all’accaparramento, al solo fine di arricchire le collezioni del Real Museo partenopeo...
È per questa ragione che a Napoli si conserva grande parte di questo patrimonio dei territori sudditi. Per la Puglia, si tratta di importanti reperti, come l’affresco «delle Danzatrici», un capolavoro unico della pittura del IV sec. a.C., scoperto a Ruvo nel 1833 da un canonico, che lo cedette al sovrano. La medesima sorte subirono gli affreschi degli ipogei di Egnazia (Fasano), del III sec. a.C., ritrovati nel 1846 e sequestrati e trasferiti nel museo napoletano nel 1850. Identico destino toccò a migliaia di oggetti archeologici, di importanza più o meno documentaria, o vere opere d’arte: come il cratere del «Pittore di Dario» (un artista-ceramista apulo operante a Taranto nel IV sec.), scoperto nel 1851 a Canosa; o come il cratere del «Pittore di Licurgo» (IV sec.), ritrovato ad Altamura nel 1847... La lista sarebbe cospicua, ma rimandiamo i curiosi all’assaggio fornitone nel catalogo della mostra «I Greci in Occidente. La Magna Grecia nelle collezioni del Museo Archeologico di Napoli», tenutasi nel 1996 (Electa Napoli ed.): in queste pagine, indicativi – e davvero interessanti per la Puglia – sono i contributi di Raffaella Cassano riguardante Ruvo, Canosa ed Egnazia, e di Ida Baldassarre sui materiali tarantini. Quest’ultima lamenta che «il Museo di Napoli infine, considerando acquisiti alle sue collezioni questi materiali (...) rifiuterà sempre le richieste di restituzione avanzate a più riprese da Taranto, anche in epoche recenti»! Quella mostra, con tanto di catalogo, sembrava la categorica risposta del Museo archeologico partenopeo per rivendicare il definitivo possesso di un patrimonio (che, per di più, fino a poco fa era praticamente invisibile al visitatore) che avrebbe dovuto fare «ritorno a casa», nei musei nazionali di Puglia. D’altronde quella collezione archeologica napoletana era in parte formata da donazioni al sovrano, e in parte acquistata con i denari di tutti i sudditi del regno. Quindi anche dei pugliesi...
In questi ultimi anni abbiamo assistito alla sbandierata iniziativa del Ministero, «100 opere d’arte tornano a casa», che prevedeva il ritorno dai depositi di grandi musei ai territori di origine di oggetti d’arte e di reperti (progetto che, insieme a tanti musei centrosettentrionali, ha interessato anche Matera, grazie - non è peccato sospettarlo - al lucano Massimo Osanna, ora direttore generale dei musei). Allora la domanda è: non sarebbe opportuno che anche questo patrimonio - del tutto secondario rispetto alla ricchezza archeologica vantata dalla Campania, e irrilevante per le sorti del Museo di Napoli - torni, almeno in parte, nei nostri musei nazionali?